La prima volta che ho incontrato Piotr è stato di spalle, anzi, ad essere preciso, la prima cosa che ho visto di lui è stata la sua schiena nuda. Alla vernice della sua mostra, L’inquilino del terzo piano (azzurrino, beigeolino, grigetto) presso il Museolaboratorio ex Manifattura Tabacchi di Città S. Angelo, era dentro una piccola stanza circolare con le pareti a cupola (una neviera), seduto di spalle ai visitatori, con Sasha concentratissima a tatuare un elaborato motivo di carta da parati. L’immagine era abbastanza raccapricciante, un po’ per il sangue che usciva dalla pelle e che si confondeva con l’inchiostro color seppia usato nel tatuaggio, un po’ per la mascherina igienica indossata da Sasha che la faceva sembrare una sadica serial killer alla Saw, un po’ per il tatuaggio che campeggia tra le scapole di Piotr e che rappresenta un grande teschio di cervo (Schiena).
All’inizio pensavo a una performance sado-maso estrema, in realtà dopo un po’ Piotr si è rivestito di tutto punto e ha iniziato, come niente fosse – non come uno che era stato per più di un’ora piegato a metà dentro una cella soffocante e surriscaldata mentre gli punzecchiavano la schiena –, a illustrare le varie opere che compongono la mostra e le performance musicali che hanno inframmezzato la serata. La presenza di Piotr è fondamentale nella mostra. Mentre spesso gli artisti si nascondono dietro i loro lavori, Piotr è parte integrante dell’opera e le sue parole, lontane dall’essere didascaliche o semplicemente descrittive, tendono invece a coinvolgere l’osservatore nella dimensione narrativa di cui l’oggetto è solo un epifenomeno. Tanto più che gli oggetti che compongono le opere sono spesso elementi banali presi dalla vita (e dall’appartamento di Piotr), ricombinati o ricontestualizzati per divenire parte di un racconto artistico. La loro quotidianità trae in inganno come è successo a me che durante la mostra, afflitto dal maldischiena, mi sono seduto sull’unico divano presente nella sala. Quando ho scoperto che si trattava di un’installazione della mostra sono scattato in piedi imbarazzato (tipico esempio di “sindrome Remo e Augusta Proietti”), una reazione che rivela quanto lo stesso oggetto, una volta rivestito dell’aura (o dell’etichetta) dell’arte, venga percepito in modo completamente differente e generi nuovi comportamenti e reazioni nei suoi fruitori.
Più che all’opera in sé Piotr sembra interessato a sperimentare le diverse forme d’interazione che l’arte e l’artista instaura con il suo pubblico ed è in questa logica che ci ha tenuto a invitarci, dopo il primo incontro, nel suo appartamento del terzo piano e a prepararci con le sue mani il pranzo (per gli amanti del gossip culinario, pastasciutta e trancio di pesce con contorno di patate e verza). Questa doppia veste di padrone di casa e artista è strettamente intrecciata e diviene asse portante della stessa mostra. Un’ambiguità voluta e ricercata, tesa a rendere sfocati ruoli e identità codificate, tanto che non si capisce più se sia l’artista performativo che mesce il vino rosso mentre siamo seduti sul divano di casa oppure se sia il padrone di casa che racconta di papaveri e soldati polacchi dell’ultima guerra nella sala del museo.
—————–
Ci racconti come sei arrivato a Pescara?
Stavo a L’Aquila e poi L’Aquila è scomparsa. Sono stato molto fortunato perché sono stato accolto da una piccola rete di amici che avevo qui a Pescara. Fra questi, Francesca de Rubeis mi ha aiutato tantissimo dopo il terremoto. Così, mi sono trovato qui, l’inquilino del terzo piano.
Eri a L’Aquila il 6 aprile?
Ero a Tornimparte, a 20 chilometri da L’Aquila, nel lato fortunato della zona. I miei ora sono rientrati a casa, che fortunatamente è rimasta in piedi.
Dopo il sisma siete stai nei campi oppure avete trovato subito una sistemazione autonoma?
Nei tre giorni e nelle tre notti successive io e i miei genitori abbiamo dormito insieme in macchina. Di giorno faceva caldo e non ci si poteva neanche appoggiare ai muri alla ricerca di un po’ d’ombra, per il rischio di crolli; di notte, invece, faceva freddissimo in macchina. Ho iniziato a fare un giro di telefonate e Francesca ha trovato un’amica che ci poteva dare ospitalità. Il momento più allucinante è stato quando siamo arrivati a Pescara con le nostre poche cose prese alla buona e ci siamo seduti a tavola con le posate e i bicchieri. Sono stati sufficienti tre giorni per apprezzare in maniera incredibile la normalità, quella cosa che ti sfugge, che è talmente quotidiana da essere becera, l’immanenza, il trantran. Scoprire quanto fosse preziosa quella scansione temporale fatta di piccoli riti.
Tornando ancora più indietro nel tempo, a L’aquila come ci sei arrivato?
Avevo 5 anni quando siamo arrivati dalla Polonia. Il primo ad arrivare in Italia, precisamente a Roma, è mio padre, grazie al suo lavoro di musicista. L’abbiamo raggiunto nel 1983 per poi spostarci dopo poco all’Aquila dove lui è entrato nell’istituzione sinfonica abruzzese come condirettore artistico e spalla, primo violino. All’epoca la politica italiana sull’immigrazione era completamente diversa, per cui ci è stata anche offerta la possibilità di trasformare il nostro visto turistico di tre mesi in residenza, sempre con permesso di soggiorno, che io ho rinnovato nel corso del tempo, fino al 2004 quando la Polonia è entrata in Europa. Al contrario dei miei familiari, sono l’unico ad avere ancora la cittadinanza polacca, non ho preso la cittadinanza italiana.
Per scelta?
All’inizio era per non fare il militare, poi per pigrizia. Quando è entrata in vigore la Bossi-Fini, e sono stato chiamato in questura per lasciare le impronte digitali, perché in quanto straniero dovevo essere etichettato e incasellato, ho voluto riappropriarmi di questa mia dimensione, di questo status che ho visto come qualcosa di particolare, di interessante. A me non importa essere etichettato come polacco o italiano, trovo siano limitazioni che, se portate all’estremo, creano solo scontri. Allora mi interessava essere, in qualche modo, veicolo di questa analisi, nel senso che se lo stato italiano fa un monitoraggio in cui io rientro dovendo lasciare le impronte in questura, allora io divento monitoraggio di quello che succede in Italia rispetto alla condizione dei migranti.
Come hai vissuto questo dualismo?
In realtà mi trovavo molto più a mio agio in un paese straniero, senza le sovrastrutture di quel paese, rispetto alla nazione originaria che rimaneva per me sempre un enigma. I miei genitori mi hanno fatto vivere una Polonia, nella sua storia e nelle sue tradizioni, cristallizzata, fermata al 1983. Succede spesso, a chi si integra nel tessuto sociale della nuova nazione, di riportare nel chiuso delle proprie mura tutto un bagaglio di simboli, riti e tradizioni che paradossalmente non combacia più con la realtà d’origine. Come mia forma mentis, colgo sempre il dualismo, gli estremi, e tra questi mi interessa disegnare e dipingere tutto quello che nel mezzo è zona grigia, indefinita. Tra la Polonia e l’Italia c’erano contraddizioni estreme, fortissime. Spesso uso questa formula: ogni nazione deve garantire alla propria popolazione un motivo valido per rimanere, quindi se pensi a luoghi in cui la natura è matrigna, lì ci dev’essere un welfare meraviglioso. L’Italia che cosa offre alla sua popolazione? Offre l’Italia, un paese meraviglioso, con una natura splendida, una storia incredibile, arte, livelli altissimi di espressione culturale ma, per converso, non il welfare.
Questo è il motivo per cui hai scelto di frequentare l’università in Polonia piuttosto che in Italia?
La scelta di studiare in Polonia mi permetteva di prendere due piccioni con una fava: studiare musicoterapia e creare, attraverso la musica, un ponte tra me e mio padre, tra il mio mondo, da strutturare, e il suo, già ben strutturato. Inoltre, era l’occasione per capire cosa fosse questa nazione, che tipo di storia avesse, che volti avessero le persone, che tipo di atmosfera si respirasse. Volevo capire come risuonasse questa nazione in me, che tipo di appartenenza ho rispetto a essa. Volevo andare ad arieggiare queste mie radici, come si fa col forcone quando si buca il terreno per far arrivare l’ossigeno, altrimenti c’è il rischio di marcescenza.
Dopo la laurea in musicoterapia cosa hai fatto?
Mi sono iscritto all’Accademia di Belle Arti a L’Aquila. Fin da piccolo mi sono sempre piaciute le discipline artistiche, per le quali ho sempre sentito un rispetto reverenziale, per cui l’arte si può solo contemplare, si può studiare, si possono guardare le mostre, si può essere curiosi ma non si può toccare. Immaginavo di trovare in accademia un ambiente ricco di fermenti – perché una persona che va a fare l’accademia o ha qualche problema oppure ha delle passioni veramente forti – e, invece, mi sono ritrovato di fronte una sorta di mediocrità legata all’assenza di artisti nel corpo docente. In accademia ho incontrato persone interessanti, soprattutto docenti teorici, tra i quali mi hanno influenzato in modo particolare Luca Farulli, Marcello Gallucci, Teresa Macrì, che mi ha seguito per questa mostra producendosi anche in un testo critico.
Ci spieghi come nasce l’idea dell’inquilino del terzo piano?
La mostra nasce per disperazione, perché nel momento in cui mi sono trovato a vivere a Pescara sono passato da una condizione ovattata, di quando vivevo con i miei, a una in cui dovevo far fronte all’affitto, alle bollette, alle spese per vivere.
Proprio nel momento in cui è diventato praticamente impossibile perseverare nelle mie inclinazioni artistiche, a causa delle scarse risorse economiche, ho sentito più forte dentro di me l’urgenza di esprimermi.
Ho pensato che fosse arrivato il momento di fare un passo più lungo, di tentare di esprimermi al meglio in una sorta di debutto nella società dell’arte. Ne ho parlato con Enzo de Leonibus, con cui avevo fatto tre collettive negli spazi del museo-laboratorio, e ci siamo presi un anno di tempo per strutturare questa mostra.
Il tema da cosa nasce?
Nasce dalla mia condizione, è una mia biografia in maniera velata, non troppo didascalica. Abito al terzo piano di una palazzina di Pescara, pertanto sono l’inquilino del terzo piano proprio come Trelkovski, anche lui un immigrato polacco, il protagonista del film del ’76 di Roman Polanski e, prima ancora del romanzo di Roland Topor. Tra me e il personaggio del film ci sono alcuni punti di contatto, che vanno oltre il fatto di essere entrambi polacchi e immigrati, come gli spazi di questo condominio che si affaccia su una corte interna fatta di retri di vecchie abitazioni.
Il titolo della mostra, L’inquilino del terzo piano azzurrino beigiolino grigetto, deriva dal mio appropriarmi degli spazi del museo come fossero stanze del mio appartamento. Lì divento l’ospite che accompagna i visitatori dentro il mio mondo-appartamento. Mi interessa essere il cicerone, o il virgilio o il caronte che dir si voglia, per rendere l’esperienza dell’arte contemporanea pubblica, di tutti. In questa operazione di guida sono, inoltre, accompagnato dalle musiche di Giorgio Mega e Teodoro Pace, che mi seguono durante il percorso della mostra e punteggiano ogni installazione con esecuzioni create appositamente. Quell’azzurrino, beigiolino, grigetto, sottotitolo della mostra, allude a tre colori non-colori, che non si ritrovano effettivamente negli spazi del museo-laboratorio, ma che esprimono una mia idea di forte soggettività. Tra l’oggettività di un azzurro, di un beige, di un grigio, in termini di parametri di frequenza luminosa e chi guarda, si frappongono tutta una serie di elementi che spingono verso una soggettività. Il fatto di sentire freddo ai piedi, di dover fare la pipì, di trovarsi in quel momento con un’altra persona, la stessa aria con una densità e umidità specifiche, modifica qualsiasi valore oggettivo rispetto a quello che effettivamente percepiamo. Nella mostra, e in generale nella mia ricerca, ci sono alcuni elementi ricorrenti come il gioco sulle trasparenze, le sovrapposizioni, processi che alterano l’oggettività di ciò che è, in favore di qualcos’altro di più sfuggente, quella che chiamo “la dimensione del mentre”, la dimensione che più mi interessa come ricerca artistica.
Ci spieghi meglio questa idea di “mentre” come pratica artistica?
Se consideriamo la vita come quel segno grafico che si sviluppa a partire dal punto A (nascita) fino al punto B (morte) in maniera non lineare, tra il punto A ed il punto B esiste un sistema di punti (tappe sociali, religiose, istituzionali…, o molto più semplicemente il montaggio dei nostri ricordi) che costituisce lo scheletro delle vite. Come nel gioco della settimana enigmistica, è sufficiente unire i punti. A un maggiore numero dei punti, a una più ardita dislocazione nello spazio, corrisponderà un segno composto di linee, più esclusivo e speciale. Ma se, come abbiamo assunto, ogni punto è una tappa o un ricordo, lo spazio tra un punto ed un altro, formerà un vuoto, sia esso un vuoto di potere o un vuoto di memoria, è tuttavia innegabile che anche questo vuoto tra due punti è parte della vita, è un vuoto vivo. Provvisoriamente, chiameremo tale dimensione mentre. Se dunque l’unione dei punti e delle linee che li attraversano formano la vita, saranno i suoi vuoti a essere argomento principale della mia ricerca. Mi interessa il mentre perché è la dimensione in ombra della vita.
Rispetto al mercato dell’arte, come ti poni?
Bene, non ho problemi, e in generale credo l’arte possa rientrare in un discorso di mercato. Uno dei miei artisti preferiti, anche se distantissimo dai miei linguaggi, è Santiago Sierra la cui ricerca rappresenta un nodo centrale nel discorso sulle contraddizioni tra la produzione votata verso temi sociali e l’appartenenza a un’élite. Lui sostiene di far parte di un sistema economico più complesso che ricerca nel prodotto artistico dei modelli, dei veri e propri feticci, espressione di un potere più che veicolo di temi. È quanto succedeva con i ritratti: il ritratto di Carlo V dipinto da Tiziano non esprimeva le idee di Tiziano quanto lo status del committente.
Visto che la materia della tua arte è il pensiero, hai una strategia per alimentarlo?
A parte vivere non c’è altro, nel senso che le suggestioni vengono dal quotidiano. In generale mi piace parlare con la gente, creare relazioni, non è un caso che la mostra sia una piccola rete di lavoro in cui tante persone, come Giorgio, Teodoro e Sasha, esprimono la loro personale competenza.
Tornando alle nostre domande classiche, ci dici quali sono i tuoi siti web preferiti?
Uso molto internet: Vimeo, Grooveshark, Facebook, prima Myspace… Uno dei luoghi dentro alla rete interessanti per me è Spinoza.it. Per il resto trovo interessante internet da un punto di vista sociologico, per il fatto che sia lo specchio senza tabù di una società dove, non a caso, la pornografia impera indisturbata. Se non sai cosa vuoi è pericolosissimo, io stesso non facevo altro che scaricare intere discografie, filmografie, che poi finivo per non guardare e non ascoltare, solo per appagare il senso di possesso o per dare un’immagine/idea di me.
Ora continui a scaricare compulsivamente?
Adesso scarico, consumo e cestino.
Hai delle riviste preferite?
Riviste d’arte, in genere. Mi sembra molto interessante ciò che sta facendo Art Tribune, ma quella che compro più spesso è Flash Art. Credo che sia per occhi smaliziati, per chi ha pelo sullo stomaco, per chi sa leggere in maniera critica, sapendo chi scrive, quali sono le sue motivazioni. In generale mi piace tantissimo guardare le figure…
Libri?
C’è stato un libro importante, letto quando avevo 17 anni, che mi ha messo profondamente in discussione, La nausea di Jean-Paul Sartre. Da allora ho fatto molta fatica a trovare libri da leggere, preferisco la saggistica, qualcosa di filosofia, libri intellettualoidi.
Tv?
Zapping compulsivo. Quando ho dei periodi di abbrutimento cambio canale con una ritmica abbastanza scandita, in realtà non è un’operazione che mi piace, è una forma di depressione.
La città in cui vivresti?
Adesso farò il trombone: Cicerone diceva Patria est ubicumque est bene, cioè la patria è ovunque una persona si trovi bene, un po’ come dire, se uno sta bene con se stesso riesce a stare bene ovunque… vabbè, diciamo Berlino o magari Cracovia.
Musica?
Ho avuto sempre un rapporto conflittuale con la musica avendo mio padre musicista e la musica è diventata qualcosa che mi fa compagnia. In genere faccio delle playlist in rete e poi ascolto mentre disegno, cucino…
Rispetto al tuo lavoro quali sono le qualità imprescindibili?
L’importante è crederci.
Quali sono gli aspetti su cui pensi di dover lavorare per migliorarti?
Ho intenzione di lavorare sulla relazione tra il contemporaneo ed il pubblico col fine di tradurre questo distacco in comunicazione. Poi, ci sono una miriade di aspetti che mi auguro di affrontare nel corso del tempo.
Nel tuo futuro cosa ti aspetti di trovare?
Ci sono delle cose che dovrò fare nel più o meno immediato futuro, nello specifico due progetti artistici, uno a Roma novembre 2012 e uno in un luogo da destinarsi nel 2013. Queste sono cose che so, per il resto è tutto terribilmente vago, ma mi piace così. Cerco di non proiettarmi troppo nel futuro e di non indietreggiare troppo nel passato, perché il rischio è quello di perdere la contingenza del presente, farsi passare la vita affianco, perdere di lucidità. Sarei felice di potermi esprimere artisticamente come ho fatto per questa mostra che mi ha dato tantissimo, in termini di formazione, di crescita personale e artistica.
Una preoccupazione?
A parte affitto e bollette? Non mi sento particolarmente preoccupato, sono sereno.
Ci fai il nome di qualche persona che ti piacerebbe farci incontrare?
Iniziamo con la lista delle persone che hanno fatto parte dell’entourage di questa mostra: Sasha l’avete già incontrata, Giorgio Mega e Teodoro Pace, che hanno realizzato la musica che accompagna dal vivo lo svolgersi della visita alla mostra. Mio padre Andrzej, violinista, Carlo Nannicola fondatore della webzine Culturame, la stilista Emanuela Cavallaro, il brand Faites Comme Chez Vous, il compositore Luigi Pizzaleo e poi una sfilza di artisti: Enzo de Leonibus, Francesca de Rubeis, Paride Petrei, Matteo Fato, Alessia Armeni, Lisa Wade, Rebecca Agnes, Adalberto Abate, Giuseppe Stampone… e poi tanti, tanti altri.
LINKS:
piotrhanzelewicz.wordpress.com
—————–
foto di Pippo Marino
slideshow su flickr

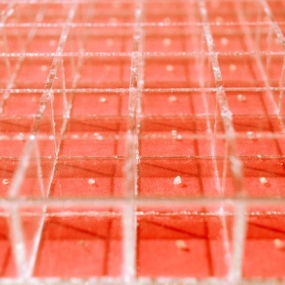

Sindrome Remo e Augusta Proietti! Ho rivisto la sequenza da “Dove vai in vacanza?”, meravigliosa…
e poi al 6’45” c’è anche Franco Summa, entro le quattro mura antiche :)
rimanere nella storia per aver fatto il muro su cui si appoggia la signora Augusta mentre si fa massaggiare i piedi è il massimo a cui un artista possa aspirare!
L’inizio dell’intervista con “Stavo a L’Aquila e poi L’Aquila è scomparsa.” difficilmente lo dimentico
Pippo marino i tuoi occhi raccontano mirabilmente le meraviglie nascoste in tutte le case, che attraverso il tuo sguardo paiono (o sono) ogni volta da rivista…lovvo!
grazie,
commosso
.
sai, fermo restando la bravura di pippo (yes pippo, un giorno dovrai anche tu ammetterlo) mi interrogavo su questa cosa, del fatto che le immagini siano da rivista. Le immagini sono belle tanto da poter apparire su una rivista oppure è il format “rivista”, in questo caso il blog, che rende belle le immagini?
(questi sono gli effetti di una anche minima frequentazione di Piotr…)
È l’ occhio dell’autore e del narratore.
Segnalo un video con Andrzej Hanzelewicz che esegue una composizione per violino “L’inquilino del terzo piano – azzurrino beigeolino grigetto” per l’omonima mostra
http://www.youtube.com/watch?v=Ig-xYusRW8Y
si, l’aquila scomparsa, si, la bellezza è negli occhi di chi guarda, e sì: il video di mio padre:)
molto molto bravi tutti!
ciao Piotr, ma quand’è che fai il finissage?
Tienici informati!